Simulacri digitali: quando la narrazione prende il posto della realtà
Nel libro di Andrea Daniele Signorelli una riflessione su come il technomarketing possa plasmare il futuro più della tecnologia
Cosa accade quando nella società dei consumi le simulazioni o le imitazioni della realtà diventano più reali della realtà stessa? Andrea Daniele Signorelli, giornalista esperto di tecnologie digitali, nel suo libro “Simulacri Digitali” - partendo da questa domanda figlia delle riflessioni del filosofo Jean Baudrillard - ci accompagna lungo il confine sempre più evanescente tra esperienza e rappresentazione, tra storytelling e opportunità concreta, tra ciò che è e ciò che viene raccontato.
Pensiamo, per esempio, al metaverso, presentato come grande rivoluzione destinata a cambiare il modo di lavorare, socializzare e fruire cultura. Pensiamo agli investimenti miliardari, alle migliaia di conferenze e alle campagne pubblicitarie che hanno contribuito a costruire una grande aspettativa presto sgonfiata dalla realtà: ambienti virtuali deserti, visori diventati oggetti destinati a prendere polvere, una Meta che ha riallineato la rotta verso orizzonti più praticabili. Questo è quello che nel libro viene descritto come il meccanismo della “profezia che si autoavvera”: prima si annuncia un futuro grandioso, poi si raccolgono fondi e attenzione, infine si prova a realizzarlo (non sempre con il successo atteso). Funziona anche se la tecnologia non è pronta: la narrazione crea le condizioni economiche e politiche per avvicinarsi alla promessa.
“In alcuni casi – scrive Signorelli nel libro – può esserci la volontà di dare vita, tramite queste narrazioni di futuro, a una profezia che si autoavvera; in altri può esserci qualche barlume di collegamento con la realtà. Nei casi estremi non c’è invece altro se non la hybris – necessariamente fallimentare – di dare forma al futuro con la sola forza della propria volontà (e dei propri mezzi economici), cercando addirittura di far deragliare quel percorso di integrazione tra tecnologia e società che fino a qui è sembrato chiaramente (ma non deterministicamente) delinearsi”.
Questo schema si ripete oggi con l’intelligenza artificiale alla quale sono dedicati un paio di capitoli. Intelligenza Artificiale descritta come panacea e rivoluzione in grado di trasformare profondamente la nostra società, tecnologia in grado di muovere cifre da capogiro in pochi anni, una narrazione e un linguaggio intriso di toni che richiamano concetti vicini alla religione: si parla di “singolarità”, di “entità superiori”, di “momenti storici”, trasformando a volte i CEO in profeti e i laboratori in templi.
Dietro questo alone mistico, però, non si nasconde un’intelligenza onnisciente, visto che – per quanto riguarda l’AI generativa - al momento attuale ci riferiamo a un insieme di sistemi statistici addestrati a imitare il linguaggio umano o a generare contenuti potenzialmente corretti e un potere di fascinazione frutto proprio dalla capacità dei sistemi di interagire con noi in linguaggio naturale. Nulla di soprannaturale: parliamo di un prodotto umano, con i limiti e i bias dei suoi creatori.
Questa aura “religiosa” porta con sé due effetti pericolosi secondo Signorelli: da un lato sposta l’attenzione dai problemi concreti (come la sorveglianza di massa o le possibili discriminazioni che derivano dal ricorso a decisioni algoritmiche), dall’altro, rischia di diventare un alibi per concentrare ulteriore potere economico e politico nelle mani di pochi.
Cosa fare allora?
“Simulacri digitali” non è sicuramente un libro contro la tecnologia, ma un invito a non fermarsi alla superficie, a non antropomorfizzare le macchine, a non credere che esista un destino già scritto. È anche un meraviglioso invito a chi fa informazione a ritrovare il senso profondo del costruire contenuti e a tutte le altre persone a ritrovare un ruolo attivo di cittadinanza.
“Abbiamo bisogno di una informazione sana che – al netto delle innegabili difficoltà economiche – smetta di essere il megafono delle Big Tech e torni a esercitare spirito critico. E abbiamo bisogno di una politica che non penda dalle labbra degli imprenditori tecnologici, che non si rivolga a loro per comprendere potenzialità e criticità delle tecnologie, ma che migliori la sua competenza in questo settore cruciale, imparando ad agire in modo autonomo per il bene della società (come sta già avvenendo, tra mille limiti, a livello europeo). E infine abbiamo bisogno che, grazie a informazione e politica, si diffonda una maggiore conoscenza e consapevolezza tra i cittadini, fornendo loro gli strumenti necessari per difendersi dalla potenza (soprattutto) del marketing e dello storytelling”.
La conclusione è, pertanto, un manifesto di consapevolezza: possiamo e dobbiamo discutere, regolare, immaginare un futuro che sia ancora nostro. Prima che il simulacro prenda il posto della realtà.




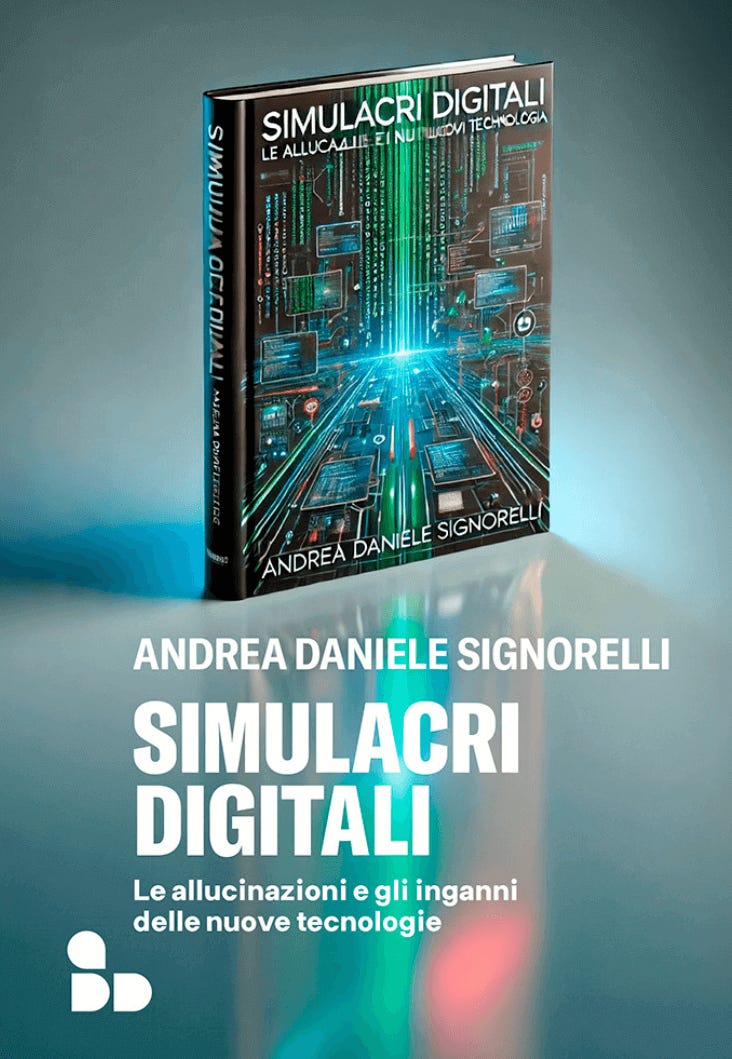
È da anni che suggerisco di introdurre nei modelli guardrails contro la nostra tendenza ad antropomorfizzare! Purtroppo senza alcun successo.